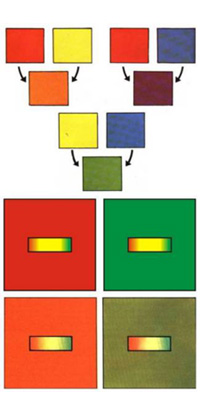|
La relazione
tra colore e lunghezza d'onda, tra percezione e dato numerico,
è analogo alla determinazione del diapason e delle isofoniche
in campo acustico. Preso un campione di persone e sottoposte
ad una serie di test cromatici è stato possibile determinare
la relazione tra composizione spettrale e colore. La commissione
internazionale che si occupa di questi fenomeni (CIE, Commission
Internationale de l'Eclairage) ha definito tre opportuni parametri:
brillanza, tono e saturazione. In questo senso possiamo immaginare
come, anche in chiave sottrattiva, una superficie perfettamente
liscia e una ruvida dello stesso colore risulti più chiara
dell'altra. Il fenomeno è legato alla differente capacità
di riflettere la luce da parte delle due superfici; quella
più ruvida, sottoposta ad ingrandimento, presenta tante piccole
escrescenze che riflettono la luce in molteplici direzioni
e la deviano rispetto all'osservatore producendo un coefficiente
di brillanza (o di riflessione) puntuale (misurato rispetto
ad un punto, l'occhio) più basso di una lucida, traendo in
“inganno” la nostra percezione. Ogni colore ci appare con
proprietà di brillanza differenziate e autonome a prescindere
dall'intensità d'emissione. Inoltre ammesso che sia possibile
ottenere una perfetta riproduzione dello spettro cromatico
con lunghezze d'onda tutte di pari intensità non è difficile
immaginare come il processo della percezione ci faccia apparire
alcuni colori, al cospetto di altri, con maggiore presenza
e più luminosi.
La
computer grafica oggi ci permette di capire meglio i fenomeni
percettivo-cromatici potendo dosare percentuali e intensità
dei colori con una precisione fino a qualche anno fa impossibile.
Il confronto digitale e analogico tra le due immagini (relative
alla misurazione del “peso” percettivo di relazione tra i
colori) mostra impietosamente le notevoli differenze tra le
due tecniche di rappresentazione.
|